- 19 dic 2024
- Tempo di lettura: 1 min
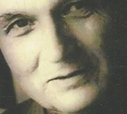
In Posizioni Derrida si esprime in questo modo rispondendo a una domanda: “In primo luogo, dif/ferenza rinvia a un movimento (attivo e passivo) che consiste nel differire (...)”p. 47. L’interprete non dovrebbe sorvolare con noncuranza sulla potenza intransitiva di quell’ossimoro attivo-passivo. Una attività che si annulla in una passività e una passività che si annulla in una attività esprime in altro modo il luogo im/presente della différance. Esclude che la sua evidenza inevidente possa mostrarsi nell’attitività di un differirsi di qualcosa, come quando si afferma ad esempio A è differente da B o A si differisce da B, o anche, ancora, A si differisce in un B, come se questo differire fosse nell’attività di un reciproco delimitarsi o del delimitarsi dell’uno rispetto all’altro. Come se la différance fosse nel relarsi di due momenti e avesse in questi relati il suo coefficiente di evidenza. Come se l’evidenza del differire fosse un’auto evidenza data dai relati differenti. Quando Derrida esclude l’attività dal differire più o meno direttamente esclude, deve escludere, questo genere di differire. Esclude che la différance sia l’attività dei differenti. Lo esclude poiché questa attività dei differenti è uno dei miraggi della metafisica. Accade alla metafisica poiché il suo gesto inaugurale e la sua forza costituente non vedono ciò che non è presente in alcun luogo, così in questo caso non vede il luogo senza presenza di questa differenza di A e B. Non vede l’im/presente di questa presenza differenziale. Vede l’attività differenziale mentre non vede o nasconde l’inattività, l’intransititività né attiva né passiva per cui A e B sono differenti

